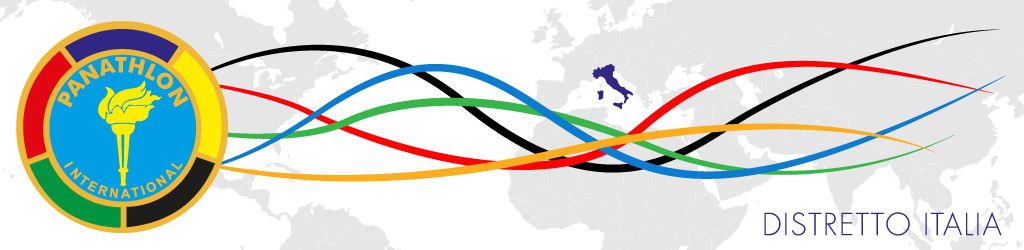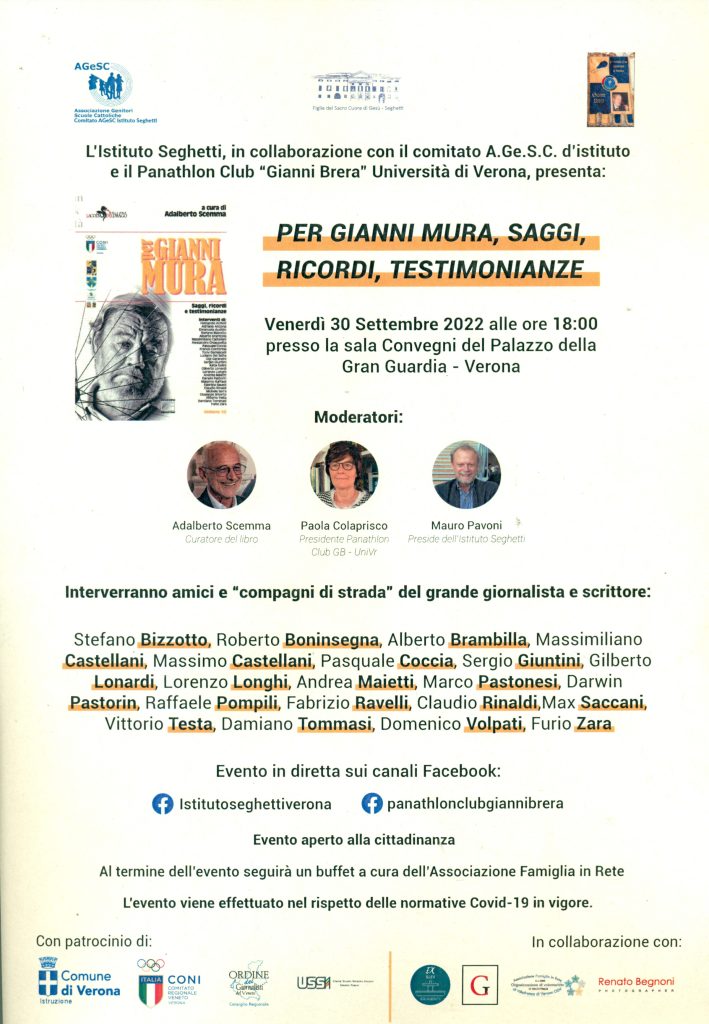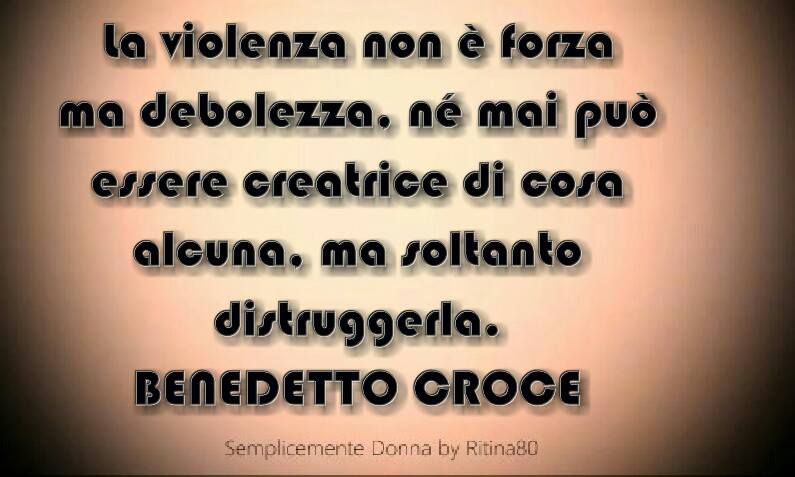Redazione Gianni Brera Università di Verona Area1 Veneto – Trentino/AA
di Valentina Masotto*
Un omino con le ruote/ Contro tutto il mondo /Un omino con le ruote /Contro l’Izoard/ E va su/ Ancora /E va su…

Cerco le radici di Fausto Coppi nella canzone, splendida, di Gino Paoli e vedo un omino senza la faccia da campione. Il suo cognome non sembra nemmeno degno di essere scritto con la lettera maiuscola: è un banale figlio di braccianti agricoli alessandrini. Soltanto le lettere minuscole gli si addicono, minuscole come la sua statura.
Fausto ha una struttura ossea e muscolare molto fragile, un fisico apparentemente poco atletico con gambe lunghe e sottili, a tal punto che, agli occhi degli spettatori, la salita pare per lui molto più faticosa. Nonostante ciò, ha una capacità toracica formidabile e un apparato cardiocircolatorio talmente efficiente da compensare l’anatomia esile con un’agilità eccezionale e, soprattutto, una resistenza sotto sforzo fuori dal comune.
Montanelli così lo tratteggia nel giro del 1949: “Coppi è quasi un rachitico. Soltanto il torace ha sviluppato: è largo come quello di un boxeur, ma le sue braccia sono esili, la vita sottile, il profilo aguzzo di una faina. La forza di Coppi è la sua fragilità: è un’antilope e ne condivide tutte le bizze. Un fuscello può farlo scartare bruscamente”.
Bastano poche proposizioni in sequenza per descrivere il profilo di una persona un po’ buffa a vedersi. Si dice che non sappia camminare, sembra un pinguino, un anatroccolo, perciò non può fare altro che pedalare. E come nella fiaba di Andersen in cui il brutto anatroccolo si trasforma in un bellissimo cigno, anche Coppi, da volatile impacciato, ha compiuto la sua evoluzione. Infatti, ormai non lo si riconosce più come “Fausto”, ma come il “Grande Airone”.
Sulla sua bici non pedala, ma vola, ha ali al posto delle gambe, che dispiega fino ai due metri: le salite non sono più un ostacolo. La forza per scalarle risiede tutta nel suo cuore, un cuore grande, un cuore appassionato, un “cuore nato per correre”.
Su, sempre più su, da solo contro il vento fino alla cima nevosa più alta: stiamo parlando del Colle dell’Izoard, che Coppi ha valicato in Francia trionfando per ben due volte.
Il mito di Fausto Coppi nasce nella primavera del 1940, quando a soli vent’anni entra a far parte della Legnano, la famosa squadra capitanata da Gino Bartali, che ha già vinto due giri d’Italia e nel 1938 il Tour de France.
Prima di allora, dopo aver frequentato con scarso rendimento le scuole elementari e affiancato il padre e il fratello maggiore nel lavoro dei campi, a tredici anni aveva iniziato a lavorare come garzone in una salumeria a Novi Ligure. Il giovane Coppi effettuava consegne in bicicletta, ricevendo una paga settimanale di cinque lire e tornando dai genitori ogni domenica. Quel mezzo di locomozione non sarà più solo un ausilio per accelerare i trasporti, ma diventerà proprio lo strumento che permetterà all’uccello trampoliere di spiccare il volo.
A quindici anni, con i soldi regalatigli dall’omonimo zio Fausto, poté comprare una Maino da 520 lire e cominciare a partecipare alle prime corse non ufficiali. È proprio a Novi che venne segnalato a Biagio Cavanna, il famoso massaggiatore di Costante Girardengo e di Learco Guerra, che lo ammise alla sua scuola di giovani corridori da poco aperta a Pozzolo Formigaro.
Cavanna, che diventerà cieco nel 1938, sarà per molti anni, anche dopo l’inizio della carriera professionistica di Coppi, suo massaggiatore ed è lui a intravedere le possibilità per il giovane Faust odi diventare un campione.
Fausto, al primo anno da professionista, entrò nella squadra del grande Gino come semplice gregario. Gli capitò tuttavia, approfittando di una caduta di Bartali, di vincere il suo primo Giro d’Italia. Come si usa dire, morto un papa se ne fa un altro: i vecchi proverbi italiani non sbagliano mai, la caduta fisica di un campione segnò l’inizio di una nuova leggenda.
Gino Paoli scrive e canta: “Qui da noi per cinque volte/Poi due volte in Francia/Per il mondo quattro volte”. Ebbene sì, il grande ciclista si aggiudicò due volte il Tour de France nel 1949 e nel 1952 e cinque volte il Giro d’Italia (1940, 1947, 1949, 1952 e 1953) ed entrò nella storia per essere stato uno dei pochi ciclisti al mondo ad aver vinto Giro e Tour nello stesso anno. Fu un portabandiera, un alfiere, un celebratore del tricolore italiano nel mondo, un patriota a 360°.
Parlando di Fausto, il lessico militare è più che pertinente: quando arrivò a Milano in maglia rosa il 9 giugno del 1940, il giorno dopo l’Italia entrò in guerra. Arruolato nell’esercito come fante, venne trasferito a combattere sul fronte africano dove, fatto prigioniero, resterà per due anni.
Anche dopo essere rientrato dal fronte, non si può certo considerare la sua vita “tutta rose e fiori”: nonostante avesse combattuto militarmente tanto quanto sportivamente per l’Italia, quest’ultima non lo ripagò affatto con eguale moneta. A un certo punto non ha più potuto dedicarsi all’ascolto del respiro della natura, del canto degli uccelli, avvertire il silenzio delle montagne, lo scroscio della pioggia e il candore della neve come gli anni addietro. Era da solo “contro tutto il mondo”.
Prima la morte del fratello Serse e poi la denuncia per essersi innamorato di una donna già sposata, la Dama Bianca, a cui dedicò la vittoria nel campionato del mondo su strada a Lugano nel 1953. Coppi trionfava per l’Italia ma l’Italia lo premiava condannandolo a due mesi di carcere nel marzo 1955.
Dopo la guerra e la condanna per adulterio, le tragedie non finiscono qui, l’ultima delle quali gli costa la vita. A 40 anni compiuti, nel capodanno del 1960, il “Grande Airone” smette di volare, smette di combattere “Lassù/Contro il cielo blu”. A causa di una malaria banalmente non diagnosticata dai medici, il grande cielo blu non è più lo scenario delle sue battaglie sportive; ora è la sua nuova dimora, dove non si sente più solo: qui può finalmente condividere i colori bianco-celeste sempre indossati che lo hanno accompagnato su tutte le strade bianche, fino al raggiungimento della fama di “Campionissimo”.
*Valentina Masotto è allievo della Quinta G del Liceo Scientifico a indirizzo sportivo Belfiore di Mantova